Lo scorso 24 Giugno alla Casa del Cinema di Roma, in occasione del Medfilm Festival 2013, è stato proiettato My Child, un documentario del turco Can Candan sull’universo psicologico e sociale della diversità sessuale. Il film racconta il dramma dell’«outing» attraverso le parole dei genitori di ragazzi gay, lesbiche, bisessuali e transgender, intervistati per ricostruire la storia di una sofferenza in via di elaborazione.
My Child (Benim çocuğum), di Can Candan, Turchia 2013, 83′
Sceneggiatura: Can Candan
Montaggio: Gokce Ince
Fotografia: Koray Kesik, Oguz Yenen
Produzione: Can Candan, Ayse Cetinbas, Gokce Ince, H. Metehan Ozkan
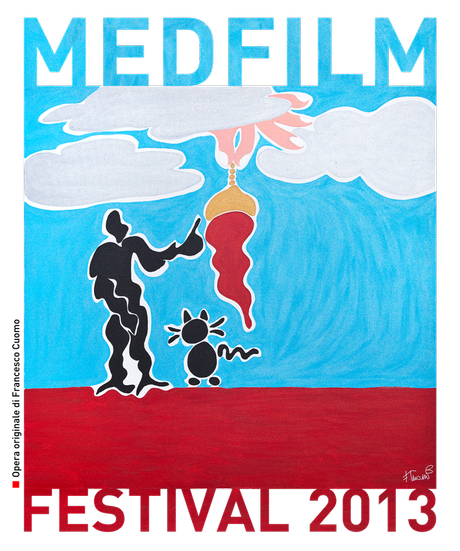

My Child non è solo un documentario sull’omosessualità; è in primo luogo un documentario turco sull’omosessualità. Non si recepisce fino in fondo la portata provocatoria e scandalosa di questa indagine, se non la si considera alla luce del contesto specifico nel quale è stata concepita e prodotta. La Turchia è sì uno dei pochi paesi a prevalenza musulmana in cui l’omosessualità non è, di diritto, considerata reato, ma essere gay o lesbiche costituisce di fatto un enorme dramma culturale, una realtà dalle tragiche implicazioni psicologiche e sociali. La transessualità poi, come apprendiamo dalle parole di una delle madri intervistate, è considerata una sorta di malattia, uno strano e mostruoso scherzo della natura.
Il progetto di Can Candan, inoltre, appare tanto più «vitale» e funzionale in un periodo in cui la Turchia, attraversata trasversalmente da moti di ribellione contro la politica reazionaria di Erdoğan, manifesta i segni di un’incontenibile esigenza di emancipazione. Inquadrato in questa ottica, il film si presenta come una sorta di “manifesto” per la liberazione dal pregiudizio e dall’intolleranza; non a caso, infatti, ad essere intervistati sono tutti quanti attivisti di Listag – l’associazione dei familiari di ragazzi gay, lesbiche, bisessuali e transessuali – quasi a voler determinare una reazione a catena negli spettatori, un invito all’adesione, all’apertura dello sguardo.
Non pochi, dopo la visione del film, hanno ammesso di scorgere dentro di sé le tracce di una cultura omofoba: consapevolezza stimolata da una rappresentazione decisamente anti-moralistica della familiarità del pregiudizio. In una parola, la paura è normale, tutto sta nel comprendere il meccanismo che la attiva e le cause concrete da cui prende vita. A questo proposito, in una sequenza del film ci viene presentata un’assemblea di genitori presieduta da medici psichiatri incaricati di gettar luce sulla «questione sessuale» al fine di scardinare tutta una serie di inesattezze – culturalmente ereditate – presenti nel giudizio comune circa la natura dell’omosessualità. Il merito fondamentale del lavoro di Candan consiste dunque nel presentare l’omofobia come una forma di ignoranza, e non di cattiveria. La paura è una dimensione della fragilità, non del male.
Il film è suddiviso in due grossi blocchi: il primo è una raccolta di testimonianze sul graduale e faticoso processo di outing e sulla sofferenza psicologica connessa al fenomeno; il secondo è la storia della trasformazione di quel dolore, di una lunga elaborazione e della scelta “militante” di una lotta attiva per l’emancipazione culturale. Ciò che colpisce è la quasi totale assenza dei figli e l’interesse incentrato sul dramma di chi assiste, di chi non è coinvolto se non indirettamente, di chi comprende che il suo coinvolgimento è indiretto solo apparentemente, giacché il dramma del singolo è realmente il dramma di tutti. In questa ottica, la questione sessuale sembra scivolare in secondo piano assumendo le sembianze di un’occasione di riflessione su un problema più ampio, che lascia emergere dallo sfondo il bisogno istintivo della condivisione, un desiderio incontenibile di comunità.

