In gara nel Concorso Ufficiale del MedFilm Festival, Premio Amore e Psiche, Rock in The Casbah racconta la storia di alcuni soldati israeliani durante la prima Intifada palestinese. Soldati che non sono nient’altro che ragazzi, con i loro sogni, le loro paure, le loro incertezze, le loro increspature.
Rock in the Casbah, di Yariv Horowitz, Isr/Fra 2012, 93’
Sceneggiatura: Guy Meirson, Yariv Horowitz
Fotografia: Amnon Zalait
Montaggio: Isaac Sehayek
Musiche: Assaf Amdursky
Suono: Michael Legum, Gil Toren
Produzione: Topia Communications

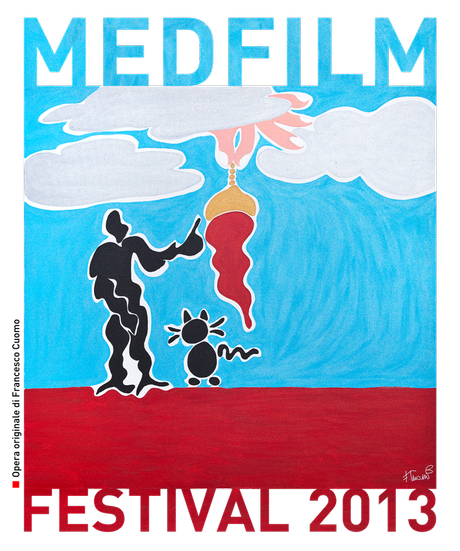
Striscia di Gaza. 1989.
Durante la prima Intifada palestinese l’esercito israeliano invia pattuglie di soldati a controllare il suo territorio.
Questi soldati sono ragazzi.
Hanno due caricatori per i loro mitragliatori, dai quali mai si separano, neanche sotto la doccia. Uno blu e uno rosso. Uno con proiettili di gomma e l’altro con proiettili, punto.
Quando arrivano nella Casbah si rendono subito conto che lì non è come immaginavano: la realtà è ben peggiore.
Come dicevano i Clash: «allo sceriffo non piace che si suoni il rock nella casbah», e lo sceriffo viene attaccato.
Uno dei giovani soldati muore schiacciato da una lavatrice lanciata da un tetto. I suoi compagni da quel momento vivranno dall’alba al tramonto piantati sopra quella casa per scongiurare altri attentati del genere; una casa in cui vive una delle centinaia di famiglie abitanti la striscia di terra più sanguinosa del pianeta. Senza l’informazione pubblica e film del genere non ci si renderebbe conto della situazione vissuta da queste popolazioni, anzi dall’odio vissuto da queste popolazioni.
Soltanto la notte i ragazzi tornano al campo base, dove ad aspettarli trovano ogni giorno la madre di uno dei ragazzi palestinesi fatti prigionieri nelle retate successive all’uccisione del loro commilitone. «Dov’è mio figlio, dov’è?» domanda la donna incessantemente. E la stessa cosa la vorrebbe sapere il padre del ragazzo ucciso, mentre disperato batte la testa sul petto del comandante della squadra singhiozzando. «A cosa servono questi ragazzi qui? A cosa serve questa guerra?». Ognuno cerca suo figlio, ognuno cerca una ragione, ognuno vive una guerra che regala dolore da ambedue le parti.
Non c’è un vincitore, probabilmente non ci sarà mai. I ragazzi tuttavia restano di vedetta, con uno stereo a fargli compagnia, un cane adottato tra le vie della Casbah, il Muezzin che intona il Corano, da insultare, e i pensieri e le paure di un qualsiasi altro loro coetaneo. Il confronto che ne esce fuori è un’introspettiva psicologica. Nessuno vuole sparare, nessuno si rende conto di quanto sia distante casa in realtà, nessuno crede che si possa impazzire in quella situazione, in quella tensione, tra tutti gli sguardi delle persone che li circondano, bambini compresi. Non si gioca sulla striscia di Gaza. Neanche a 5 anni. Nessuno tranne uno dei soldati lo fa: Tomer, forse colui che capisce davvero la follia di tutto ciò che gli accade intorno e vorrebbe soltanto avere la certezza di poter tornare a casa, per vivere «una vita felice, senza increspature». Finalmente i ragazzi abbandonano il tetto e forse il campo base. Arriveranno comunque altri soldati, altri ragazzi, con i due caricatori di diverso colore, uno che mette paura, l’altro che la cancella.

